 II
castello tranese compare, documentato, a partire dal 1233, in due
occasioni:
II
castello tranese compare, documentato, a partire dal 1233, in due
occasioni:
la prima, in un passo della cronaca di Riccardo da S. Germano (p.
1081 ) in cui il cronista dichiara: « Castella in Trano, Baro,
Neapolj et Brundisio iussu imperatoris fìrmantur», termine
quest'ultimo controverso e fin dal latino classico alternativamente
inteso nell'accezione di rafforzare, consolidare ovvero edificare
dalle fondamenta; la seconda nella più antica iscrizione presente
nel castello stesso, situata nel cortile occidentale su un ampio portale
a doppio arco ogivale.
Nel 1234 Federico è segnalato a Trani, giuntovi allo scopo
precipuo di « vedere la fabbrica dello castello » (SPINELLI,
p. 1065), castello che nel 1239 viene compreso nell'elenco dei castra
exempta, direttamente dipendenti dal sovrano, regolarmente munito
di castellano di nomina regia e di una guarnigione composta da ottanta
elementi. Già nel 1240 il castello presenta necessità
di urgenti riparazioni alle volte lesionate. Ai lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria di cui necessitano tutti i castelli del
regno contribuiscono città opportunamente designate. Le spese
relative al castello di Trani vengono sostenute dalle città
di Trani e Molfetta, prassi che rimarrà in vigore nel successivo
periodo Angioino. A conclusione delle opere di fortificazione intanto
eseguite al castello si pone una seconda iscrizione, collocata sull'antica
porta a mare tompagnata, ad ovest, nel muro di cinta. Datala 1249,
essa fa riferimento alla costruzione di tale elemento difensivo, condotto
circum et ante la rocca; vi sono segnalati i nomi dell'autore
del progetto, Filippo Cinardo, e del realizzatore materiale dell'opera,
il tranese Stefano di Romualdo Carabarese.
Dimora favorita di Manfredi, nel castello si celebrarono le sue nozze
con Elena d'Epiro (1259), ivi catturata da Carlo I d'Angiò
in seguito alla disfatta di Manfredi a Benevento (1266).
Passato sotto la tutela angioina il castello vedrà dimezzarsi
il suo apparato difensivo, ridotto a quaranta elementi negli anni
precedenti il 1269, quindi aventi con le Costitutiones serventium
in castris Regni.
La documentazione fornita dalla consultazione dei registri della cancelleria
angioina nella edizione del Filangieri, consente di delineare un quadro
completo della vita del castello negli anni compresi tra il 1266 ed
il 1288. La fortezza funge da organo di controllo sugli elementi perturbatori
dell'ordine all'intemo della città, da prigione politica e
da temporanea dimora delle figlie del sovrano e del rè stesso,
quando le abitudini itineranti della sua corte lo portano a Trani;
viene scelto quale sede per la celebrazione di matrimoni fastosi,
le seconde nozze di Carlo I d'Angiò con Margherita di Nevers
(1268) e quelle del figlio Filippo con Isabella Comneno (1271); i
quaderni e gli scritti dei conti razionali vi vengono trasferiti da
Nocera, il tesoro regio vi viene temporaneamente custodito; funge
da deposito di materiale bellico, e più tardi non solo bellico,
a disposizione della Corona, nel primo caso per approvvigionare di
munizioni l'esercito regio, nel secondo per rifornire le casse private
del sovrano.
Il castello dispone di un cospicuo arsenale a cui il sovrano attinge
per l'armamento del suo esercito: ferro ed acciaio da forgiare, quadrello
e balestre, lance, uniformi; vi sono inoltre custodite migliala di
libbre di cera, nonché merci preziose come pepe, cannella,
zucchero e bombice.
In quanto ai lavori strutturali effettuati al castello in epoca angioina,
essi si limitano ad alcune generiche riparazioni castris et pontis
Trani; cui si aggiungono la realizzazione delle bertesche e la
costruzione di camini nella zona residenziale del castello, ad opera
dell'ingegnere Giovanni di Toul.
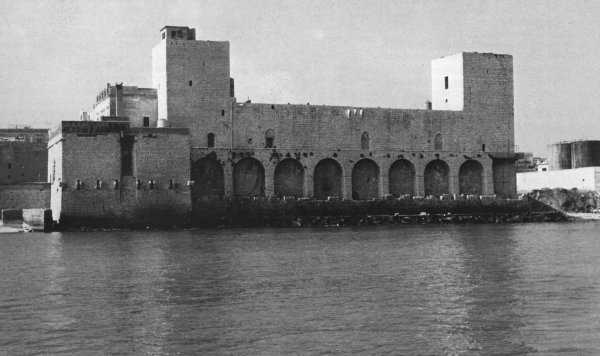 L'ultima
regina angioina, Giovanna II, nel 1425 ed il primo rè aragonese,
Alfonso I il Magnanimo, nel 1436 ribadiscono in due importanti documenti,
custoditi nel Libro Rosso dei Privilegi della città di Trani,
il principio che sempre la città ed il relativo castello saranno
demaniali e dipendenti unicamente dalla corona. Nel 1458 la città
si ribella minacciando di impadronirsi del castello; la rivolta è
sedata in nome del rè Ferdinando da Antonio Fuxa, provveditore
dei castelli del regno. L'episodio è degno di nota perché
la narrazione dell'evento illumina e sull'esistenza all'intemo del
castello di una scuderia di apprezzabili dimensioni (Fuxa si avvale
di quaranta cavalieri per compiere la sua impresa) e sulla diversa
sistemazione delle difese quattrocentesche, tali da permettere il
passaggio della cavalleria all'interno e lungo i fianchi del castello.
L'ultima
regina angioina, Giovanna II, nel 1425 ed il primo rè aragonese,
Alfonso I il Magnanimo, nel 1436 ribadiscono in due importanti documenti,
custoditi nel Libro Rosso dei Privilegi della città di Trani,
il principio che sempre la città ed il relativo castello saranno
demaniali e dipendenti unicamente dalla corona. Nel 1458 la città
si ribella minacciando di impadronirsi del castello; la rivolta è
sedata in nome del rè Ferdinando da Antonio Fuxa, provveditore
dei castelli del regno. L'episodio è degno di nota perché
la narrazione dell'evento illumina e sull'esistenza all'intemo del
castello di una scuderia di apprezzabili dimensioni (Fuxa si avvale
di quaranta cavalieri per compiere la sua impresa) e sulla diversa
sistemazione delle difese quattrocentesche, tali da permettere il
passaggio della cavalleria all'interno e lungo i fianchi del castello.
L'apparato difensivo del castello si va intanto evolvendo con i tempi:
un mandato di pagamento vi documenta nel 1494 la presenza di due bombardieri,
divenuti trenta nel 1539. Dal 1496 al 1530 la città di Trani
e relativo castello non dipendono più dalla Corona spagnola,
passando temporaneamente sotto la giurisdizione della Serenissima
in pegno di un prestito pecuniario. Nel 1496 il Senato veneto delibera
la elezione di un governatore e di un castellano per Trani; nel 1500
il Consiglio dei Dieci ordina la chiusura di due porte minori del
castello di Trani prospicienti il mare, pericolose per la sicurezza
della rocca in quanto permettono ogni tipo di contrabbando. Al 20
febbraio 1530 risale lo strumento della riconsegna della città
di Trani e del castello, fatta in nome dei rispettivi governi da Giovanni
Vitturi, provveditore veneto, a Ferdinando de Alarcon, capitano generale
di Carlo V. Passato sotto la tutela imperiale, il castello attira
immediatamente l'attenzione del nuovo sovrano; al 1533 risale infatti
la terza iscrizione presente nel castello, collocata al limite superiore
del secondo piano, nella parete sud del cortile centrale.
La ristrutturazione dell'ala meridionale del cortile, cui l'iscrizione
fa riferimento, conferisce all'edificio squisite caratteristiche rinascimentali,
sovvertendo l'ormai consunta compagine federiciana. Si procede, inoltre,
date le mutate tecniche belliche con ampio impiego di armi da fuoco,
all'ispessimento della parete esterna della stessa ala ed alla cimatura
delle torri ad essa collegate. Trovato in buone condizioni ed atto
alla difesa in una ispezione del 1536, il castello viene corredato
dell'unico torrione lanceolato, caratterizzante l'angolo sud-ovest,
completato nel 1540 con la costruzione della merlatura, costata sedici
ducati e quattro tarì. Nel 1541 compie un'ulteriore ispezione
al castello di Trani il viceré don Pedro da Toledo, il quale
provvede a concedere sovvenzioni e suggerisce che una torre debba
innalzarsi per una più efficace protezione del fianco prospiciente
il mare, torre identificabile nello sperone quadrangolare scarpato
posto all'angolo nord-est.
Al 1533 risale la quarta iscrizione presente nel castello; sormontata
dallo stemma di Carlo V e situata sull'architrave dell'attuale portale
di ingresso, ne data la strutturazione. Alla seconda metà del
sec. XVI risalgono alcuni inventari di munizioni e vettovaglie custodite
nel castello, relativamente agli anni 1551, 1561, 1584, nei quali
vi sono interessanti accenni alle attività inteme al castello,
nella attenta descrizione, fra l'altro, del materiale contenuto nella
ferrarla e nel mulino.
In quanto all'attività edilizia, definibile importante e prestigiosa,
degli anni '30 e '40, fa riscontro nei decenni successivi una stasi
quasi totale, tale da legittimare un radicale mutamento di funzioni
del castello tranese.
 Nel
1583 Filippo II comunica al viceré di Napoli il proprio desiderio
che la sede della Sacra Regia Udienza della Provincia di Bari venga
stabilita nel castello di Trani, data la sua inadeguatezza a fungere
da valida fortezza militare.
Nel
1583 Filippo II comunica al viceré di Napoli il proprio desiderio
che la sede della Sacra Regia Udienza della Provincia di Bari venga
stabilita nel castello di Trani, data la sua inadeguatezza a fungere
da valida fortezza militare.
Il 5 luglio 1586 ha luogo l'inaugurazione del tribunale della Sacra
Regia Udienza nel castello tranese, dove tale istituzione ebbe sede
fino al 1677. Nel castello di Bari è custodito un interessante
plastico ligneo del castello di Trani; esso consente una agevole lettura
della struttura e dei passaggi originari, precedenti le vistose alterazioni
subite dall'edificio nel secolo scorso.
Un inventario del 1730, peraltro non diverso da quelli in precedenza
citati, fornisce l'elenco degli ornamenti della Real Cappella, sita
in un vano ancora privo di copertura nel plastico.
In un documento del 1798, un messaggio diretto dal castellano al preside
della S.R. Udienza, fornisce un quadro avvilente della decadenza dell'edificio;
nei primi decenni del secolo successivo, dopo la restaurazione borbonica,
il castello risulta essere sede, rovinosa e bisognevole di continui
accomodi e ripristini, di una caserma e relativa prigione. Il 6 giugno
1831 il castello di Trani passa per ordine del rè dal Ministero
della Guerra e Marina al Ministero degli Interni « per poter
istabilirvi il carcere centrale ».
Sgombrato dell'artiglieria nel 1832, il castello subisce una massiccia
ristrutturazione, realizzata nel trentennio 1832-1863, attestata da
una nutrita documentazione - sopralluoghi, rilievi, progetti, stime
e scandagli - raccolta in cinque cartelle presso l'Archivio di Stato
di Bari. La lettura delle cartelle suddette informa dettagliatamente
dei lavori svolti: costruzione di nuovi quartini, chiusura di porte,
finestre e freccere, nuove aperture praticate a colpi di piccone nell'antica
fabbrica, tompagnatura delle antiche scale e realizzazione di nuovi
collegamenti, riassetto totale delle coperture e delle pavimentazioni,
costruzione delle garitte.
Lo studio dell'ingente materiale cui si è fatto cenno ha consentito
di ricostruire la consistenza e le caratteristiche del castello prima
dell'impropria destinazione a carcere, nonché di datare finalmente
con certezza elementi dalla controversa attribuzione cronologica,
quali:
- la cappella esistente nel cortile centrale, edificata nel 1842 allo
scopo di celebrarvi la messa per i detenuti;
- il camminamento e relativi pilastri di sostegno esistenti nel cortile
centrale, realizzati per permettere l'accesso dall'esterno in diversi
ambienti del primo piano, previa chiusura dei preesistenti collegamenti
tra le antiche sale e parziale trasformazione delle antiche finestre
affacciantesi nel cortile centrale;
- il camminamento a ridosso della cortina a mare, lato Nord, con i
relativi archi e pilastri di sostegno, edificato per consentire alle
sentinelle di tenere sotto controllo l'intera fascia perimetrale del
castello;
- il ponte di unione tra mastio e piazza antistante il castello;
- i collegamenti verticali ed in particolare: la scala visibile nel
primo cortile e che conduce al primo e secondo piano del braccio est;
- la scala che ha sostituito l'originaria (sottostante alla stessa
e rimessa in luce nel corso dei lavori) e che collega il ballatoio
pensile del cortile centrale con il secondo piano del braccio sud;
- i piani intermedi in muratura nelle torri sud-est, nord-ovest, nord-est;
 Gli
interventi effettuati dal 1832 per la nuova destinazione del complesso
non hanno causato profondi danni, rimaneggiamenti o demolizioni alle
strutture preesistenti, alle quali i nuovi elementi strutturali si
sono semplicemente addossati. Con la stessa logica, ad integrazione
delle strutture esistenti, tra la fine del secolo scorso e l'inizio
del 1900, vennero edificati nei cortili laterali intemi e a ridosso
delle torri nord-est e sud-est alcuni corpi di fabbrica, demoliti
durante i recenti lavori di restauro.
Gli
interventi effettuati dal 1832 per la nuova destinazione del complesso
non hanno causato profondi danni, rimaneggiamenti o demolizioni alle
strutture preesistenti, alle quali i nuovi elementi strutturali si
sono semplicemente addossati. Con la stessa logica, ad integrazione
delle strutture esistenti, tra la fine del secolo scorso e l'inizio
del 1900, vennero edificati nei cortili laterali intemi e a ridosso
delle torri nord-est e sud-est alcuni corpi di fabbrica, demoliti
durante i recenti lavori di restauro.