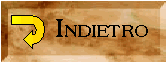|
La cappella, anch'essa con altare con paliotto in legno,
si caratterizza per due tele raffiguranti S.Giovanni della Croce
e l'Estasi di S.Teresa. Nel primo dipinto il santo in
ginocchio e posto di profilo tende le mani verso il Cristo, in tunica
rossa e manto azzurro, che gli è apparso sulle nubi, piegato sotto il
peso della croce. Accanto a S.Govanni della Croce si trovano altri due
santi, uno sorregge un libro con il braccio destro e con il ginocchio
sinistro puntato per terra, mentre l'altro si china ad osservarlo recando
uno stelo di giglio fiorito. In alto si trova una schiera di angeli
che intrecciano serti di rose e dalla bocca del santo escono le parole
"DOMINE PATI ET CONTEMMI PRO TE".
Nell'altro dipinto, proveniente dalla chiesa di S.Teresa delle Donne,
la santa, in abito dell'Ordine, ha il viso levato in alto e le braccia
aperte in gesto di preghiera, mentre due angeli la coronano dall'alto
ed altri due volano festosi.
Nella iconografia della santa il tema dell'estasi risulta essere molto
ricorrente, infatti, non va dimenticato che insieme a S.Giovanni della
Croce, ella ebbe una forte esperienza mistica (testimonianza ne sono
i loro numerosi scritti). Ad immortalarla in uno dei suoi slanci si
è cimentato, con grandissimo successo, anche il Bernini con una scultura
alla quale lavorò dal 1644 al 1651 su commissione della famiglia Cornaro.
L'opera testimonia la grande abilità di questo artista nella tecnica
compositiva e nella lavorazione del marmo. Alcuni critici ritengono
che in questa opera vi sia una sorta di ambiguità nell'abbandono della
santa, la quale sembra in preda ad un'estasi d'amore terreno piuttosto
che divino. L'ambiguità è però giustificata da un'analisi degli scritti
di S.Teresa. Una mescolanza di spiritualità e di sensualità è tipica
del suo misticismo, lo testimoniano le parole: "certi slanci d'amore
segreti, ma infuocati, mi dicono chiaramente chi è il mio Dio che mi
da vita…sento vivissimi tali trasporti amorosi…Dio fa scaturire in copia
il latte delle celesti consolazioni, che infonde nuova vita, non soltanto
nelle potenze dell'anima, ma anche nei sensi del corpo". La composizione
tuttavia testimonia che lo scultore conosceva molto bene gli scritti
della santa la quale in una lettera successiva ad un'estasi scrive:
"L'anima mia si riempiva tutta di una grande luce, mentre un angelo
sorridente mi feriva con pungente strale d'amore". Bernini l'ha
raffigurata proprio in questa maniera: le vesti scomposte, le palpebre
abbassate, la bocca dischiusa e un angelo sorridente nell'atto di scagliare
una freccia in direzione del suo cuore. La composizione è illuminata
da una finestra ovale posta nella cupoletta della nicchia, che conferisce
al panneggio dell'abito della santa e all'angelo dei forti toni di chiaroscuro.
Lo scultore ha poi realizzato un palchetto nel quale ha collocato alcuni
membri della famiglia Cornaro che, assistendo all'estasi della santa,
accentuano il forte senso di spettacolarità di quest'opera a testimonianza
della grande importanza data durante tutto il Seicento al teatro e alle
sacre rappresentazioni.
In linea con l'iconografia scelta dal Bernini sono alcune tele, di Luca
Giordano, presenti nella chiesa di S.Teresa degli Scalzi a Napoli, realizzate
verso al fine del '600 ed un'altra tela proveniente da S.Teresa delle
Donne, attualmente collocata alle spalle dell'altare maggiore di S.Teresa
dei Maschi. Il riferimento all'enfasi dell'opera berniniana è fondamentale
per cogliere l'importanza attribuita nel '600 alla rappresentazione
teatrale, avallata anche dal Concilio di Trento che aveva dato il suo
parere favorevole allo spettacolo visivo come strumento di insegnamento
religioso ed edificazione morale.
Anche la cattedrale di Bari, infatti, divenne luogo di rappresentazione
di drammi teatrali sotto la guida del già citato vescovo Ascanio Gesualdo
che può considerarsi il continuatore della cultura riformistica avviata
dal cardinale Puteo a Bari.
Come viene detto nella Storia di Bari nell'Antico Regime (a cura di
F. Tateo) "con lui e dopo di lui quella cultura si svilupperà senza
remore e censure e tradurrà gli apparati liturgici, gli altari provvisori
e le macchine effimere delle feste nelle forme scenografiche della decorazione
di interni e negli elaborati ornamenti di suppellettile e arredi".
Anche nelle architetture questo è sin troppo evidente e la chiesa di
S.Teresa dei Maschi ne è conferma.
|