|
Nella presa dei fotogrammi i raggi proiettivi partono da ogni punto dello spazio oggetto e,
attraversando il punto nodale della camera, arrivano sulla superficie fotosensibile formando così l'immagine.
Per entrambe le immagini della coppia (immagini omologhe) ci sarà dunque un fascio proiettivo con centro nel punto nodale.
L'operazione di orientamento consiste nel ricostruire il luogo delle intersezioni tra le infinite coppie di raggi ottici omologhi dei due fasci in questione, ovvero ricostruire
un modello ottico simile al nostro oggetto.
Se si vuole ricreare un modello nello spazio sono necessarie due immagini diverse, prese da
punti diversi, che dovranno essere disposte tra di loro nella stessa posizione di presa.
Questa operazione è nota come
orientamento relativo dei fotogrammi. Fissato un sistema di riferimento (sistema relativo)
con origine nel punto nodale di una delle due camere, il problema si risolve con la conoscenza della posizione
della seconda camera, in particolare di tre parametri di traslazione lungo gli assi coordinati e tre
parametri di rotazione intorno agli stessi.
Nella geometria proiettiva è dimostrato che, se 5 coppie di raggi omologhi
si intersecano nei rispettivi punti oggetto, allora anche le restanti coppie si intersecheranno.
Tradotto, significa che bisogna conoscere almeno 5 punti omologhi, presenti in entrambi
i fotogrammi per poter effettuare l'orientamento relativo.
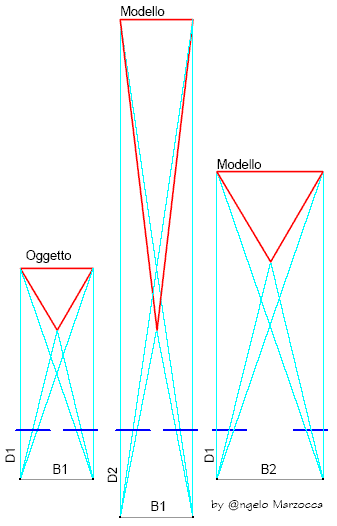 Dal momento che l'osservazione andrà fatta con base e distanza pricipale diverse da
quelle di presa, ne risulterà che il modello apparirà diverso dall'oggetto reale.
Nello specifico: Dal momento che l'osservazione andrà fatta con base e distanza pricipale diverse da
quelle di presa, ne risulterà che il modello apparirà diverso dall'oggetto reale.
Nello specifico:
- aumentando o riducendo la base, a parità di distanza principale e di fotogrammi si avrà rispettivamente un modello ingrandito o rimpicciolito, proporzionale all'oggetto reale;
- aumentando o diminuendo la distanza principale, a parità di base e di fotogrammi, si avrà rispettivamente un modello allungato o accorciato dunque deformato rispetto all'oggetto.
In generale nel campo dell'architettura, la visualizzazione avviene con basi ridotte e con
distanze principali aumentate (da 25cm a 1m), questo significa che si avrà un modello
rimpicciolito e allungato; quest'ultima caratteristica è vantaggiosa ai fini della misurazione in profondità.
Con il solo orientamento relativo otteniamo così un modello simile all'oggetto da cui
possiamo conoscere solo le posizioni relative tra i vari punti. Per poter effettuare delle
misurazioni, con riferimento ad un sistema assoluto di coordinate spaziali,
bisogna dimensionare il modello, rapportandolo in scala all'oggetto, e posizionarlo nello spazio.
Per eseguire tale operazione, detta di orientamento assoluto, necessitano almeno sette
parametri nelle due alternative:
- 2 punti di posizione nota (x,y,z) e 1 punto di quota nota (z);
- 2 punti di posizione piana nota (x,y) e 3 punti di quota nota (z);
Il suddetto procedimento viene denominato orientamento esterno,
definito prendendo come centro di vista N' dell'obiettivo e come parametri le sue tre coordinate spaziali e le tre coordinate angolari intorno ai tre assi
principali della macchina. Di queste ultime, l'angolo definito dalla rotazione intorno all'asse per la
verticale viene solitamente misurato da un teodolite annesso alla camera, gli altri due, che ne
definiscono lo sbandamento vengono solitamente resi nulli bloccando la camera. Le tre coordinate spaziali sono note essendo rappresentate dalla posizione di presa dei fotogrammi.
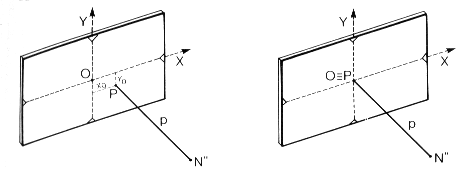 Per ogni fascio di raggi proiettivi si dovrà inoltre determinare l'orientamento interno alla camera da presa, definito prendendo come centro di vista N"
dell'obiettivo e come parametri le coordinate x e y misurate sulla superficie fotosensibile e la distanza dal punto principale P al punto nodale N" (distanza principale).
Questi parametri sono tutti noti e sono specifici della macchina utilizzata.
Per ogni fascio di raggi proiettivi si dovrà inoltre determinare l'orientamento interno alla camera da presa, definito prendendo come centro di vista N"
dell'obiettivo e come parametri le coordinate x e y misurate sulla superficie fotosensibile e la distanza dal punto principale P al punto nodale N" (distanza principale).
Questi parametri sono tutti noti e sono specifici della macchina utilizzata.
In estrema sintesi, l'orientamento si scinde in due fasi che permettono di ricostruire, rispettivamente, la posizione relativa tra i fotogrammi e la posizione nello spazio del
sistema così formato. Per effettuare l'orientamento bisogna conoscere le caratteristiche della macchina da presa (lunghezza focale e punto principale), le posizioni nello spazio dei
punti nodali (centri di proiezione) e la direzione dell'asse principale (asse dell'obiettivo). | |
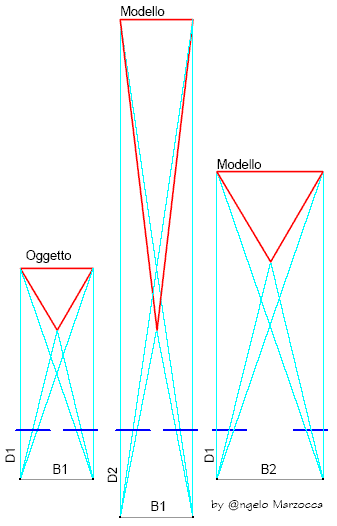 Dal momento che l'osservazione andrà fatta con base e distanza pricipale diverse da
quelle di presa, ne risulterà che il modello apparirà diverso dall'oggetto reale.
Nello specifico:
Dal momento che l'osservazione andrà fatta con base e distanza pricipale diverse da
quelle di presa, ne risulterà che il modello apparirà diverso dall'oggetto reale.
Nello specifico: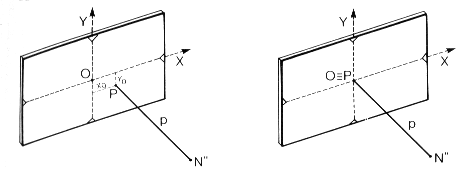 Per ogni fascio di raggi proiettivi si dovrà inoltre determinare l'orientamento interno alla camera da presa, definito prendendo come centro di vista N"
dell'obiettivo e come parametri le coordinate x e y misurate sulla superficie fotosensibile e la distanza dal punto principale P al punto nodale N" (distanza principale).
Questi parametri sono tutti noti e sono specifici della macchina utilizzata.
Per ogni fascio di raggi proiettivi si dovrà inoltre determinare l'orientamento interno alla camera da presa, definito prendendo come centro di vista N"
dell'obiettivo e come parametri le coordinate x e y misurate sulla superficie fotosensibile e la distanza dal punto principale P al punto nodale N" (distanza principale).
Questi parametri sono tutti noti e sono specifici della macchina utilizzata.