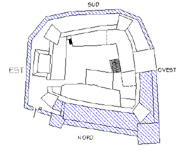L’ultima delle trasformazioni subite dal Castello durante il Medioevo, fu la realizzazione del
grandioso corpo di fabbrica e delle due torri ad esso connesse sul lato Nord del complesso
architettonico.
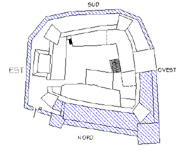
La realizzazione richiese l’interruzione della seconda cinta muraria a pochi metri dal portale
d’ingresso, in corrispondenza della nuova torre di levante.
La notevole differenza dimensionale fra le due torri connesse al nuovo corpo di fabbrica
genera dubbi sull’effettiva contemporaneità dei due manufatti.
S’ipotizza, infatti, che la torre di levante sia stata costruita sulle fondamenta di una torre
già esistente, connessa alla seconda cinta.
Ad avvalorare tale ipotesi vi è l’evidenza della connessione tra nuovo recinto e la torre di
levante, leggibile solo sui ricorsi di conci prossimi al piano di campagna.
L’ipotesi di un’evoluzione organica, ma riconducibile ad un preciso e limitato intervallo
temporale, è avvalorata anche da un elemento molto evidente, costituito dall’architrave – tipo,
adoperato diffusamente nei passaggi tra due saloni oppure tra salone e torre, presenti sia nel
corpo di fabbrica, posto all’interno della cortina Nord, sia in quello esterno e nelle torri.
L’architrave in questione è costituito da pochi conci radiali a faccia liscia, che generano un
arco in intradosso, non sempre a sesto acuto, mentre, in estradosso, si incastrano con i conci
che compongono l’apparecchiatura muraria.


Molte analogie sono riscontrabili anche tra le scalette in pietra, una posta all’interno del
salone Nord, prospiciente la corte interna, e le altre all’interno delle due torri connesse con
la cortina Ovest.
Due di esse (quella del salone e quella della torre centrale Ovest), costituite da due rampe,
l’una rettilinea e l’altra a chiocciola, se si esclude il diverso trattamento della copertura,
sono praticamente identiche per dimensioni e lavorazione della pietra; l’altra, invece, situata
all’interno della torre d’angolo Nord – Ovest, si dispiega su di una sola rampa rettilinea.


Non si hanno notizie certe circa la precisa datazione delle strutture annoverate nella terza
fase dello sviluppo del complesso architettonico.
L’originaria soluzione strutturale di copertura dei locali di piano terra con solai in legno,
poggianti su archi trasversali, richiama i castelli di epoca federiciana; tuttavia, tale ipotesi
non trova alcun supporto nei pochi documenti storici dell’epoca, anzi, nell’unica notizia
relativa al Castello, durante la prima metà del XIII sec., esso è indicato come proprietà del
vescovo di Bari.
D’altra parte, poiché dal 1304 sino al secolo scorso, escludendo il periodo che va dal 1350 al
1415, il feudo di Sannicandro fece parte dei possedimenti della Basilica di S. Nicola, non
avendo, i monaci, alcun interesse a dotare il Castello di simili strutture, prende corpo
l’ipotesi di un rifacimento effettuato proprio durante i 65 anni nei quali il feudo fu posseduto
dalla famiglia Grimaldi.
Tale ipotesi è suggerita specialmente dalla presenza dello stemma dei Grimaldi, incastonato sul
portale Est, nella parete bugnata che lo contiene, anche se l’analisi ravvicinata dello stemma
non ha fornito la prova decisiva per definire con certezza la contemporaneità di esecuzione tra
lo stesso e la foderatura della parete.